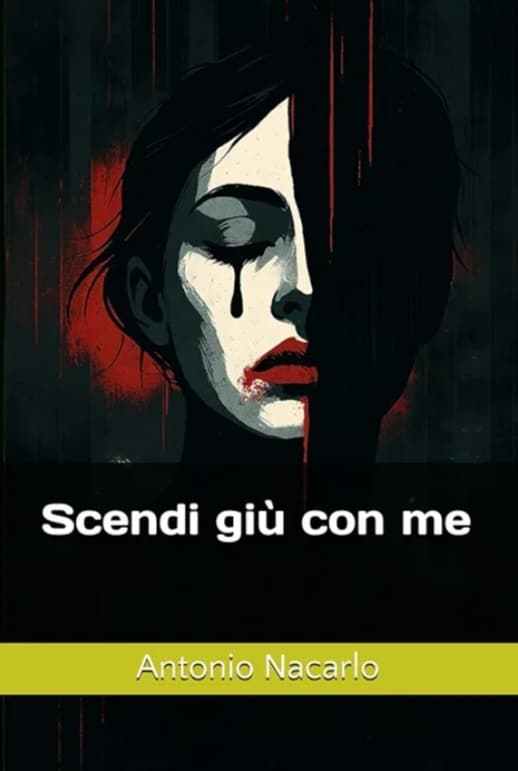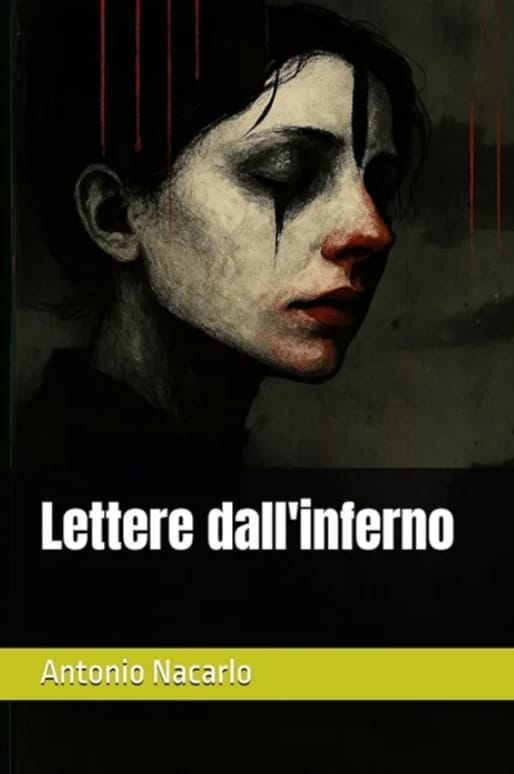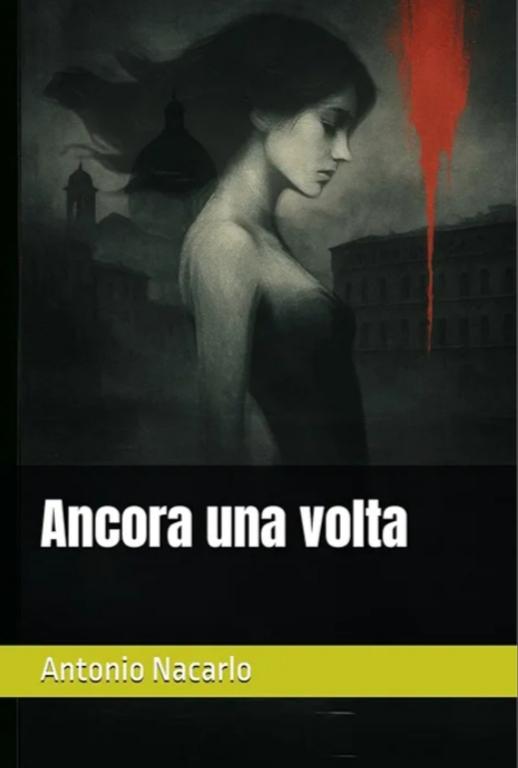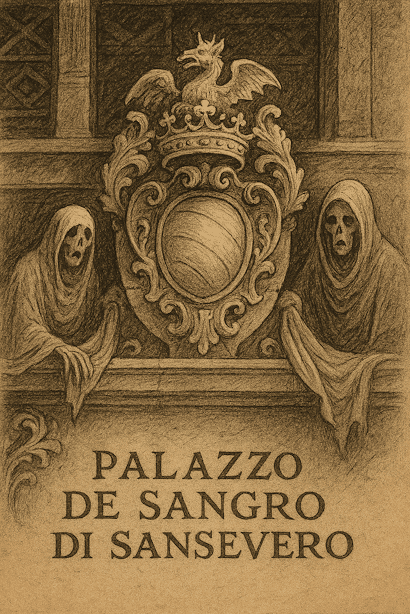Ci sono anni che restano incisi dentro come graffi sulla pelle, stagioni che diventano parte di noi senza che ce ne accorgiamo. Per me — e per un’intera generazione napoletana — quell’anno fu il 1985. L’eco del terremoto si percepiva ancora tra le strade chiuse, i palazzi scrostati e le baracche che punteggiavano i vuoti lasciati dal sisma. Napoli arrancava, ma era viva.
Era una città stanca e bellissima, ferita e fiera, con il cuore spezzato e il sangue caldo. E nel suo sangue scorreva una colonna sonora precisa: la voce di Pino Daniele.
Avevo pochi anni, ma ricordo il suono delle radio accese nei cortili, le cassette consumate infilate nei mangianastri, le note che sembravano uscire dalle finestre per andare incontro alle personee. Pino non era solo un cantante: era il battito stesso della città, la sua lingua segreta, la sua rabbia e il suo amore.
Quando uscì il suo nuovo album Napoli non sembrava più la stessa. Due mesi prima, il 23 settembre, avevano assassinato, un ragazzo, Giancarlo Siani.
Aveva ventisei anni.
Collaborava con Il Mattino, raccontava verità che nessuno voleva ascoltare. Aveva osato spiegare come politica e camorra si stringessero la mano sotto il tavolo, aveva scavato nella spartizione dei quartieri e dei soldi del post-sisma, aveva dato nomi e cognomi di camorristi e mafiosi. Per questo i killer lo aspettarono sotto casa e lo freddarono nella sua Mehari verde, a due passi da piazza Arenella.
La sua morte fu come un lampo gelido in un settembre ancora caldo. A noi bambini di allora il suo nome arrivava come un’eco lontana, sussurrata tra le conversazioni dei grandi. Ma quella morte, anche senza comprenderla fino in fondo, lasciò un segno iniziando a mutare il modo in cui guardavamo la città.
Fu in quei giorni, pochi mesi dopo quell’omicidio, che Pino Daniele pubblicò Ferryboat, e tra le tracce di quell’album ce n’era una diversa dalle altre. Si chiamava Sarà.
Non era la canzone più famosa, né quella più suonata. Ma chi la ascoltava con attenzione sentiva che c’era qualcosa di più profondo. Una voce che cercava di parlare a qualcuno — forse a una donna , forse a un’intera città — dicendole di non lasciarsi abbattere.
Voglio vede' a Maria
Ca' s'è fermato Dio e po'
Un altro mondo cresce in fretta e cambierà
Io sto tornando, meno male
---
Puorteme 'nterra 'a rena
Addò nun ce sta pere e po'
Sputa 'nfaccia a chi te sfotte e nun te dà
Non si può vivere e guardare
Qualcosa che fa male, no
Pino la cantava con dolcezza e rabbia insieme, come solo lui sapeva fare. C’era un invito alla resistenza, a sputare in faccia a chi ti ruba la vita, a non regalare la propria dignità a nessuno.
Era come se parlasse a quella Napoli sfregiata dalla camorra e dalla speculazione edilizia, a quella città che aveva appena perso un figlio coraggioso. E in quell’immaginaria Maria che la canzone chiama, qualcuno di noi vedeva il volto dei giovani giornalisti, degli idealisti, dei sognatori che non si arrendevano.
Sarà
Un'altra strada che ci sarà
Forse arriveremo in tempo
Sarà
Tutto in un momento, ah
Ascoltare Sarà in quegli anni significava sentire sulla pelle una promessa: che il futuro non era scritto, che nonostante tutto ci sarebbe stato un domani diverso. Anche se avevano ucciso Siani, anche se i cantieri restavano fermi, anche se i ragazzi migliori partivano al Nord in cerca di lavoro, Napoli avrebbe continuato a cantare e a lottare.
Nel mio ricordo di bambino c’è un’immagine nitida: le strade ancora sconnesse del Vasto, il grigio dei palazzi lesionati, e dalla finestra di una 127 azzurra la voce di Pino che riempie l’aria. Da qualche parte, nel silenzio sospeso di un autunno amaro, c’è anche una Mehari parcheggiata sotto casa, con il giornale del giorno sul sedile.
Le due immagini si intrecciano nella memoria come un riflesso proustiano: il sangue sulla strada e la musica che lo consola, il dolore di una morte e la voce che invita a non chinare la testa.
“Sarà…”
Forse Pino non pensava a Siani quando la scrisse. Forse sì, in qualche modo. Ma per chi ascoltava, quella canzone diventava anche questo: un abbraccio invisibile a chi aveva pagato con la vita la sua onestà, e un monito a tutti gli altri a non cedere.
Perché la speranza, come la verità, non si può spegnere con quattro colpi di pistola.
E oggi, a quarant’anni da quella sera di settembre, la canzone continua a parlare. A chi scrive, a chi racconta, a chi non si arrende. A tutti quelli che, come Giancarlo, credono che anche la parola — fragile e leggera come una nota — possa cambiare il mondo.
Antonio Nacarlo
📦 BOX – Chi era Giancarlo Siani
Giancarlo Siani (Napoli, 19 settembre 1959 – Napoli, 23 settembre 1985) è stato un giornalista del quotidiano Il Mattino. Giovane cronista di nera, si occupò delle attività camorristiche nel territorio di Torre Annunziata e del legame tra clan, politica e affari legati alla ricostruzione post-terremoto.
Il 10 giugno 1985 firmò un articolo che rivelava l’accordo segreto tra la Nuova Famiglia e i Gionta, mettendo a nudo il patto tra criminalità e potere. Tre mesi dopo, mentre rientrava a casa a bordo della sua Citroën Méhari, fu assassinato sotto casa con dieci colpi di pistola. Aveva appena 26 anni.
Il suo sacrificio è diventato simbolo della libertà di stampa e della lotta contro ogni forma di censura e collusione. Oggi è riconosciuto come uno dei più importanti martiri civili dell’Italia repubblicana.