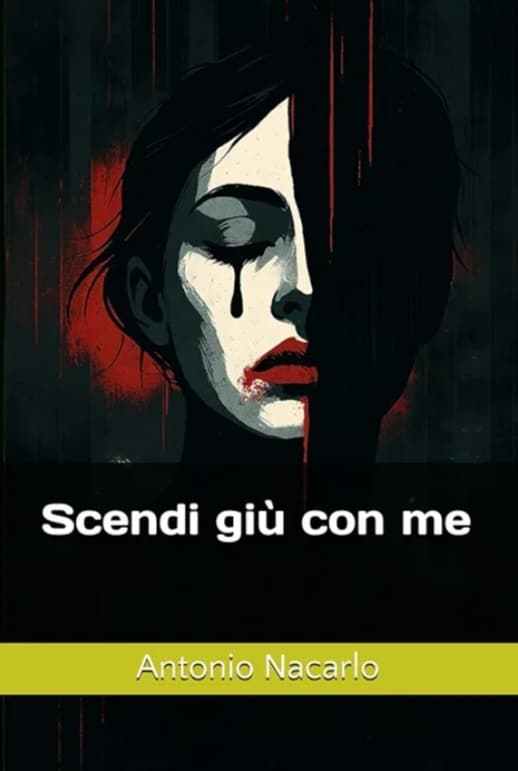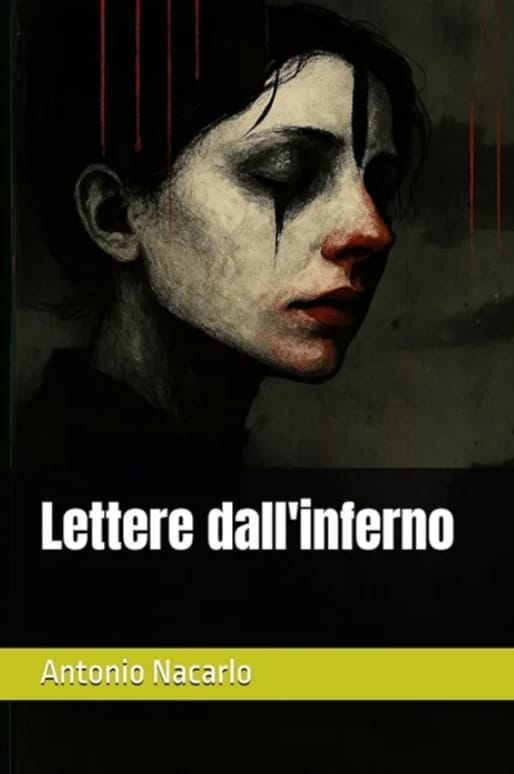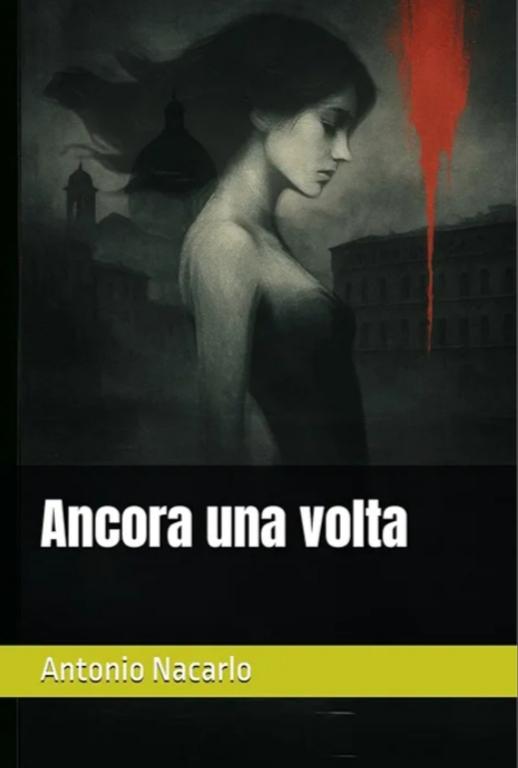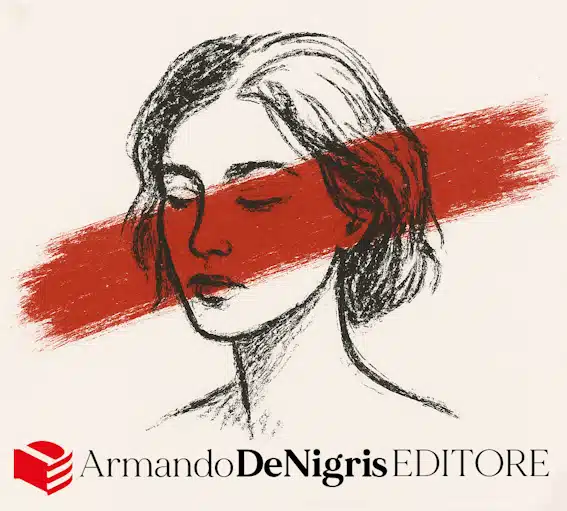Raccontare Napoli non è mai facile. È quasi impossibile non cadere nei soliti cliché di bellezza e dannazione. Napoli è spesso descritta come “il paradiso abitato da diavoli” (come scriveva Benedetto Croce), ma non è sempre stata così. Secondo lo storico inglese Danis Mahon, il giudizio negativo sulla popolazione partenopea ha iniziato a formarsi durante il dominio spagnolo nel XVI secolo. Gli oltre duecento anni di occupazione spagnola, infatti, avrebbero avuto un impatto profondo, contaminando culturalmente Napoli e i suoi abitanti.
Con l’arrivo delle truppe spagnole, la città si trasforma. Lo stanziamento forzato delle truppe e la creazione degli acquartieramenti spagnoli avrebbero, secondo Mahon, “iniettato sangue nero nel ventre” di Napoli. La superstizione religiosa, il gioco d’azzardo, il pericolo della prevaricazione e la spacconeria sarebbero quindi frutto di quell’influenza straniera. La grande presenza di uomini soli alla ricerca di “dolce compagnia” avrebbe anche spiegato l’aumento del meretricio in città.
La Napoli Sofferente del Passato
Le ipotesi storiche sono affiancate dalla realtà dei fatti: una popolazione ridotta allo stremo dalla pressione fiscale, dai terremoti, dalle frequenti eruzioni del Vesuvio, dalla peste e dalla sifilide, portata dai conquistadores dal Nuovo Mondo. Nonostante le difficoltà, gli enti assistenziali, sia ecclesiastici che laici, cercavano di alleggerire le sofferenze del popolo. Tra questi, un’importante istituzione fu la Congregazione dei Bianchi della Giustizia.
Fondata dal francescano San Giacomo della Marca nella seconda metà del Quattrocento, la confraternita aveva il compito di confortare i condannati a morte, disporre dei funerali e delle messe di suffragio, e prendersi cura delle famiglie dei condannati, salvaguardando soprattutto la prole. I membri della confraternita indossavano un saio bianco, da cui il nome, e svolgevano la loro attività con grande discrezione e pietas.
Santa Maria degli Incurabili: Un Scrigno Barocco
La sede della confraternita, la Chiesa di Santa Maria Assunta dei Bianchi, si trova ancora oggi a Napoli, inglobata nel cortile dell’Ospedale degli Incurabili, un complesso che rappresenta un gioiello dell’arte barocca. Lì, si conservano numerose opere d’arte, dalla pittura alla scultura, passando per l’ebanisteria lignea e l’intarsio marmoreo. Un altro tesoro che si trova all’interno dell’ospedale è l’archivio che racconta la storia delle esecuzioni capitali. In oltre 300 anni di attività, la confraternita ha assistito i condannati e ha registrato ben 4.000 esecuzioni, con una raccolta di oggetti personali dei condannati, tra cui le corde utilizzate per le impiccagioni.
“La Scandalosa”: Un Memento Mori Barocco
Ma l’opera che più ha colpito i visitatori di tutti i tempi è “La Scandalosa”, una statua in cera che rappresenta, con un realismo impressionante, gli effetti devastanti della sifilide sul volto di una giovane ragazza. La statua mostra i segni del disfacimento post mortem, con insetti necrofori e ratti, rendendo l’opera un raccapricciante “memento mori”, tipico dello spirito barocco.
Secondo il canonico Celano, storico dell’arte napoletana vissuto nel XVII secolo, questa statua veniva mostrata alle “giovani pericolanti” (le figlie dei condannati a morte) come monito contro la prostituzione, che molte donne, per povertà e disperazione, consideravano come una via facile di sopravvivenza. Una sorta di pubblicità progresso dell’epoca, che cercava di prevenire la caduta morale delle giovani donne.
L’Autore della Scultura e la Ceroplastica
Fino a poco tempo fa, l’autore della statua di “La Scandalosa” era ritenuto ignoto. Tuttavia, recenti studi hanno attribuito l’opera a Gaetano Zurlo, gesuita e pioniere della ceroplastica anatomica, o alla sua allieva napoletana Caterina de Julianis. Nel Seicento, infatti, si iniziò a usare la cera per realizzare modelli anatomici del corpo umano, evitando così le dissezioni clandestine dei cadaveri (vietate per legge). Questo metodo, purtroppo macabro, riusciva a riprodurre con eccezionale realismo l’aspetto umano, consentendo agli artisti di aggiungere una forte componente teatrale alla rappresentazione.
Il Barocco e la Morte: Un Tema Ineludibile
il Barocco, con il suo spirito di teatralità e drammaticità, ci racconta di un’umanità consapevole della sua finitezza. L’arte barocca, attraverso opere come “La Scandalosa”, ci invita a riflettere sulla caducità della vita. La cultura barocca, con il suo memento mori, svela un sentimento tragico del tempo, percepito come un percorso inesorabile verso la morte. L’uomo, che nel Rinascimento si sentiva il centro dell’universo, ora è chiamato a pagare il suo dazio all’inevitabile destino della morte.
Gli artisti, secondo la visione barocca, sono incaricati di mettere in scena questo percorso, esagerando e estremizzando gli stati d’animo umani. Macabri o meravigliosi che siano, i loro lavori devono suscitare orrore o stupore, facendo leva sulla pietas, un concetto centrale nella controriforma ecclesiastica.
La Morte a Napoli
Così, Napoli diventa un palcoscenico della morte, un luogo dove la bellezza e la miseria si intrecciano in un dramma eterno, tanto visibile quanto nascosto tra le sue strade e i suoi edifici barocchi. La Scandalosa, una delle opere più inquietanti di questa città, ci ricorda che la morte, nella sua ineluttabilità, è sempre presente, pronta a rendere omaggio all’opera d’arte più tragica di tutte: la vita stessa.
Fonti:
- Danis Mahon “Studies in Seicento Art and Theory”
- Gianbattista Marino “La Murtoleide”
- Carlo Celano “Notizie del Bello, dell’Antico e del Curioso della Città di Napoli”
- Benedetto Croce, Fondo degli Studi Crociani
- Salvatore Di Giacomo “Luci e Ombre Napoletane”
- Nicola Spinoza “Pittura del Seicento Napoletano”
- Renato De Falco “La Donna nei Detti Napoletani”
- Gigi DiFiore “Napoletanità”
- Mario Scansani “Gaetano Giulio Zurlo”
- Sylvain Bellenger, catalogo presentazione mostra “Storia e Mito del Seicento Napoletano”